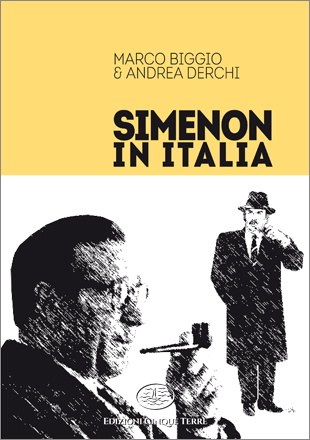Questo ricordo di Gino Patroni nasce da una mancanza dell’autore. Era stato gentilmente invitato dal giornalista Franco Carozza a intervenire il 25 novembre del 2006 a una manifestazione in ricordo di Patroni, di cui era stato collega e amico, intitolata “Quando Spezia era Parigi”, promossa dal circolo La Sprugola, dall’Accademia del Gusto con il patrocinio della Provincia, dell’Apt e del “Secolo XIX”. Avrebbe dovuto portare un suo contributo per ricordare l’umorista spezzino, ma non poté intervenire perché per motivi di lavoro si trovava all’estero. Tuttavia aveva preparato alcune pagine su Gino Patroni che costituiscono l’ossatura di questo ricordo. Pubblicarlo oggi a venti anni dalla morte dell’umorista vuole essere un modo di emendarsi per quella mancanza. Ma ha soprattutto l’obiettivo di riportare nei limiti del possibile alla memoria dei lettori che lo conobbero o di chi non lo ha conosciuto e si domanda chi sia quella figura ritratta in una lapide in via Chiodo sopra i tavoli del Bar Peola, una delle geniali personalità che più hanno illuminato lo spirito spezzino.
LE PRIME PAGINE
La fattispecie dell’umorista
“E ben distintamente, nella fattispecie, passo a salutare”.
Era uno dei suoi modi di annunciarsi in redazione. Una parodia beffarda del linguaggio burocratico. Dei magistrati. Dei questurini. Degli avvocaticchi. Dei militari. Dei funzionari statali. Consegnava quella frase stanza dopo stanza. Affacciandosi con un tenue sorriso e due occhi sottili che dietro le lenti spesse da miope lampeggiavano ironia. “Aloa, cosi diso, stan bravi?”. (“Allora cosa dicono stanno bravi?”), continuava con uno di quei tormentoni che ripeteva dieci, venti volte al giorno. Come “Cosa femo, s’ammassemo?”, che era una sorta di calembour giocato sul doppio significato nel dialetto spezzino della frase: “cosa facciamo, ci ammassiamo, ci raccogliamo?”, o “cosa facciamo, ci ammazziamo?”
“Poi, il passo dondolante, claudicante sui piedi offesi, lentamente si avvicinava a una scrivania per agguantare un portacenere. Sfilava dal pacchetto verde delle Nazionali un’esportazione (sigaretta fortissima e senza filtro), la portava alle labbra tra le dita ingiallite dalla nicotina, l’accendeva con un fiammifero. Scambiava due battute, tra il polemico e il sarcastico sulla vita cittadina. Su qualche personaggio sgradito dell’establishment locale. Lanciava un paradosso per denunciare il dissesto delle strade. La maleducazione dei marinai. Le colpe del sindaco.
Se aveva da mettere insieme un articolo si sedeva davanti alla macchina per scrivere che disponeva diagonalmente. Si sfilava gli occhiali. Senza togliersi di dosso né l’eschimo verde pesantissimo, né la vecchia berretta di lana blu da marinaio, salvo che non fosse piena estate, e cominciava a digitare di sbieco. Tutto storto. Con un ritmo da trotto macinava una cartella. Una seconda. Una terza. In dieci minuti, senza fermarsi. Senza una cancellatura. Ma tanta cenere e tanto fumo sparsi ovunque.
Finito il compito, ripeteva il giro dei saluti. Stanza dopo stanza: Ben distintamente passo a salutare.
Dopo il congedo scendeva al Bar Peola. Un caffè, decine di sigarette, decine di battute, di calembour, di aneddoti, di racconti in un frenetico carosello di persone che si fermavano o che fermava al suo tavolo.
Era lì che riceveva le telefonate dei direttori dei giornali che gli chiedevano articoli, epigrammi, disegni perché in casa non aveva l’apparecchio. Anzi erano direttamente le cassiere e i camerieri che gli trasmettevano le richieste. Spesso distorcendo completamente i messaggi dei direttori, i loro nomi e le testate. Così finiva per spedire al “Mago” un epigramma sollecitato dal direttore del settimanale “Contro”. O viceversa.
Il rito della visita in redazione – da dove prelevava un quotidiano, “Il Giorno” o “Il Corsera”, oppure negli anni Ottanta “La Repubblica” – si ripeteva puntuale due volte al giorno: poco prima di mezzogiorno e verso le sei del pomeriggio. A meno che non fosse uno di quei periodi di crisi che trascorreva al reparto neuro: quello che lui definiva la sua abitazione, mentre sosteneva di ricoverarsi a casa.
Spariva per quindici, venti giorni. Accadeva almeno in un paio di occasioni l’anno. Forse per questo nell’ambiente dei giornalisti si fece poco caso nei primi giorni del 1992 alla scomparsa di Gino Patroni. Un collega che copriva la cronaca nera scoprì che era ricoverato in ospedale, ma non per il solito tagliando neurologico. Era già in stato di semi-incoscienza. Lottava con poche speranze per sopravvivere a un attacco di cuore che l’aveva sorpreso a casa qualche giorno prima. Aveva da poco installato il telefono, arrivato con molto ritardo come il televisore.
Quando il male lo aveva aggredito, lui che dopo la morte della mamma viveva solo, aveva cercato di chiamare. Ma era caduto a terra. La cornetta era rimasta a mezz’aria. Se gli fosse riuscito di telefonare, forse si sarebbe salvato. Invece rimase sul pavimento dell’ingresso per giorni, prima che fosse soccorso. Il 7 gennaio del 1992 a 72 anni, Gino Patroni, giornalista, scrittore, epigrammista, umorista con la passione del disegno, morì. Il suo ultimo libro, pubblicato quell’anno, s’intitola Il foraggio di vivere.
La sua è stata una vita complessa. Tra angoscia. Solitudine. Fobie. Sconfitte. L’esistenza di un intellettuale di provincia di grandissimo talento e buona cultura che, come tantissimi altri, negli anni del Dopoguerra sarebbe stato accolto a braccia aperte dal successo incontrandolo negli orizzonti più vasti della grande città. Ma che è rimasto schiacciato dalle sue paure e dalle sue nevrosi. Che si è rifugiato nella placenta della provincia. Un percorso inverso a quello raccontato in quasi tutti i suoi film (e vissuto in prima persona) da Federico Fellini. Ma proprio per questo paradigmatico. Un Mastorna che non è andato in città.